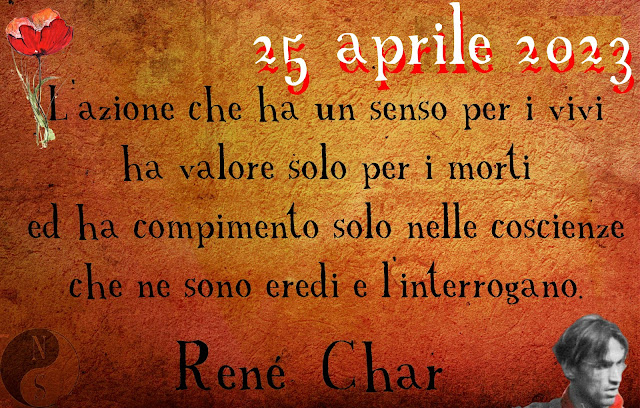Dopo la condivisione social del mio pezzo su Ferraris e la sua interpretazione di Rousseau, ne è sorto un interessante dibattito con colleghi, molti dei quali insegnano o hanno insegnato, come me, al Giannone di Benevento. Li riporto, riservandomi il privilegio, con altro post nei prossimi giorni, di chiudere il cerchio.
Dolores Morra, con la poesia connaturata al suo animo, invita a leggere la seconda delle Passeggiate del Ginevrino come «come antidoto», definendolo «un capolavoro “politico” ed “ecosistemico”».
L’amico e magister Amerigo Ciervo, invece, mi scrive questo.
«Caro Nicola, [...] non ho ascoltato Ferraris, mi fido della tua sintesi e condivido le tue critiche, Mi limito ad aggiungere un modesto contributo avendo seguito, nel lontano 1973, universitario alla Federico II, un seminario durato tre mesi e guidato dal compianto Giulio Gentile, assistente di Carbonara alla cattedra di Storia della filosofia, sul Rousseau e Marx di Galvano della Volpe, libro pubblicato da Editori Riuniti se ricordo bene a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta. Il saggio chiudeva un rigoroso lavoro teorico, dal coté marxista, sulle possibili relazioni tra il Ginevrino e Marx. Quale la tesi? Se per Rousseau l'uomo è il soggetto depositario di diritti originari, la società che egli immagina nel Contratto sociale, assume i caratteri con cui, nell'età moderna, si afferma la libertà borghese. E, dunque, all'individuo atomistico e astorico (perché analizzato al di fuori delle condizioni economico-sociali reali che Rousseau propone, sarebbe necessario contrapporre la visione dell'uomo soggetto sociale, così come Marx lo presenta nei Manoscritti del 1844). Ma fin qui non ci sarebbe nessuna novità rispetto alla tradizionale concezione marxista del pensiero rousseauiano. della Volpe, però, si interroga sul valore politico non ancora «storicamente esaurito» del filosofo ginevrino, sostenendo la necessità di distinguere radicalmente gli esiti politici dai principi ideologici di Rousseau. In tal modo il filosofo di Ginevra prospetterebbe una società che esce fuori dai parametri storici e ideologici della borghesia. È l’idea di una società egualitaria non livellatrice: una società in grado di realizzare un’eguaglianza e una giustizia fondate sul rapporto proporzionale di differenze sociali e personali basate sul merito. Un rapporto di “proporzionalità universale” assicurata dalla “forza comune” del “corpo sociale”. In tal modo, per della Volpe, il progetto politico di Rousseau non sarebbe esaurito, ma andrebbe oltre la rivoluzione borghese, fortemente contribuendo a sviluppare in avanti l'idea di democrazia. Ora è chiaro che per approfondire tali temi siano necessari tempi non brevi e, probabilmente, modalità differenti. L’incontro con Emiliano Brancaccio, per dire, è durato tre ore. In ogni caso, concordo: non lamentiamoci eccessivamente e prendiamoci tutto il buono possibile».
La carissima Carmen Caggiano scrive: «Mi sento molto vicina alle tesi formulate da Ferraris che sta facendo i conti, com'è giusto che sia in filosofia, non solo con Heidegger, ma anche con Rousseau e Kant per un nuovo realismo che ripensi il rapporto tra essere umano e tecnologia». Poi articola questo accenno in una più approfondita riflessione che riporto, supportata da alcune pagine tratte da un libro recente di Ferraris (Documanità, Laterza, 2021) dedicate all’autore del Contratto sociale.
«Provo a dire la mia opinione a proposito della lezione di Ferraris. A me pare che la lettura del pensiero di Rousseau da parte di Ferraris prescinda da quella in chiave marxista e vada a recuperare la visione propriamente roussoiana per cui l'essere umano è considerato in uno stato di natura ideale anteriore alla costruzione della società. Per parafrasare Nicola Sguera, ogni studente di quarta liceo sa che lo stato di natura viene usato dal filosofo ginevrino in senso strumentale come correttivo della società a lui contemporanea e sa che lo stato di natura è al di fuori del tempo storico. E, allora, se lo stato di natura è una condizione ideale, una condizione verso cui tendere, una condizione che non è già data, se tale condizione non è intesa come condizione di partenza, in quale modo l'essere umano di Rousseau potrebbe nascere libero? A me pare evidente uno slittamento dal piano ideale a quello storico, da quello teorico a quello della prassi, della realtà concreta (Kant direbbe dal piano del pensiero a quello ontologico) senza che vi sia, però, una giustificazione della libertà in senso storico. La libertà di cui parla Rousseau, quindi, è una libertà ideale, che appartiene al dover essere dell´uomo. È una libertà da costruire, proiettata nel futuro, non un dato di partenza.
Per quanto riguarda il pensiero ecologico, questo non è affatto svalutato da Ferraris, ma è considerato da un altro punto di vista: per Ferraris non ha senso l'espressione “salviamo il pianeta” perché noi non siamo essenziali all'esistenza del pianeta, il quale è esistito, come ci ricorda anche Telmo Pievani, prima di noi ed esisterà anche dopo la nostra scomparsa. Vista la inessenzialità nostra in relazione al pianeta, dove sarebbe l'interpretazione antropocentrica? La conclusione di Ferraris, come quella di Pievani, ci ricorda che la nostra attenzione deve concentrarsi sulle condizioni che rendono possibile la nostra esistenza completamente inserita nella natura. Noi dobbiamo salvare noi stessi e per farlo dobbiamo partire dal riconoscimento che siamo parte della natura.
Aggiungo, inoltre, che chiedersi retoricamente se si stia consapevolmente stravolgendo il pensiero di Rousseau in quanto ancora oggi rivoluzionario a me appare una domanda dal sapore complottista.
A me convince la proposta di Ferraris che non condivide l´idea per cui l'essere umano è schiavo della tecnica: dal suo punto di vista, le macchine non hanno senso senza la nostra vita, i nostri desideri e, kantianamente, tale concezione ha lo scopo di non farci uscire dalla “minorità” e di evitare di assumerci le nostre responsabilità.
Il discorso a questo punto potrebbe andare avanti, ma chiudo qui questo mio breve contributo. Mi sento molto legata ai colleghi del Giannone verso i quali nutro stima e affetto e con i quali condivido molte idee e mi sento legata da stima, affetto e profonda riconoscenza anche verso chi ha dato vita e sta portando avanti tra innumerevoli difficoltà il Festival della Filosofia del Sannio, la professoressa Carmela D´Aronzo che sta offrendo a Benevento, e non solo a Benevento, la possibilità di un confronto diretto con intellettuali conosciuti finora solo attraverso la parola scritta».
Annalisa Cervone, finissima ricercatrice, oltre che collega, scrive: «I grandi maestri sono fatti per essere smontati, decostruiti, e a volte addirittura fraintesi e traditi. Credo ci siano molteplici progetti ermeneutici e possibilità di lettura ricavabili dall'archetipo libertario e dal profilo democratico-rivoluzionario del pensiero di Rousseau (se così non fosse saremmo di fronte all'ennesima deriva ideologica sempre sottesa a un certo epigonismo di scuola); così come penso che per provare a controbattere la tesi di Ferraris avremmo bisogno (tutti noi, e anche i nostri alunni) di un convegno efficacemente congegnato, della durata di qualche giorno, e non più di un luogo ibrido, come può essere quello di un festival della filosofia che, quand'anche didatticamente meritorio (ma solo dal punto di vista della divulgazione culturale), costituisce pur sempre un dispositivo che per sua stessa natura manifesta grossi limiti proprio di tipo epistemico e procedurale (di creazione concettuale, per dirla con Deleuze)».
Teresa Simeone, infine, molto presente in questo blog come privilegiata interlocutrice in un polemos sorretto da vigorosa philia, scrive un lungo intervento. Eccolo.
«Caro Nicola, scusa se ti rispondo solo ora. Voglio innanzitutto ringraziarti perché poni sempre questioni che aprono dibattiti, stimolano al confronto e cercano di scuoterci dal torpore a cui a volte, vuoi per pigrizia, vuoi per umiltà intellettuale, vuoi per disimpegno, finiamo per cedere.
Devo riconoscere, onestamente, che condivido molte delle tesi di Ferraris: sono una progressista, confessione che so non ti sorprende, ma, mi permetto di aggiungere, del tipo critico. Non mi ha mai appassionato il mito di un’età dell’oro in cui l’umanità vivesse felice e in armonia con la natura da cui ci saremmo drammaticamente separati. Credo che il lavoro, alla cui base c’è il possesso di una mano capace di forgiare strumenti con cui intervenire sull’ambiente, matrix dell’intelligenza (Anassagora e Bruno l’hanno scritto molto chiaramente) e del suo sforzo di emanciparsi dal dominio di un pianeta non benevolo né malevolo ma certamente indifferente alle sue sorti, sia il fondamento dell’impegno a non subire, quanto a porsi come soggetto attivo di crescita. Non rimpiangerò mai il tempo in cui si era costretti a vivere in sporche e fredde casupole di paglia e fango, a non avere sistemi fognari per liberarle dal ristagno mefitico di umori ed escrementi, a dover mettere al mondo sette, otto figli per sopportarne la morte della metà, in cui i libri erano privilegi di pochi, in cui chi aveva problemi di vista era destinato alla cecità anche culturale, in cui le donne morivano di parto e si amputavano arti senza anestesia, giusto per fare qualche esempio, sicuramente banale, ma comunque concreto che rimanda a uno sviluppo che ci ha liberato da dolori e bisogni. Naturalmente, condivido la necessità di aver sempre chiaro, come un faro che ci dovrebbe orientare, il senso del limite che solo può consentire uno sviluppo razionalmente ordinato e controllato nei suoi eccessi. Anders, che tu hai giustamente nominato, ci ha messo in guardia da un uso smodato della tecnica, i cui effetti, soprattutto in riferimento all’atomica, aveva denunciato, così come il nostro caro Jonas che, nel ribadire la necessità di un’etica nuova che desse all’umanità paradigmi per preservare non solo i presenti ma gli “ancora non nati”, ha posto l’accento sul rispetto dell’ambiente. L’enciclica Laudato sì, a cui ho dedicato, come sai, numerose pagine nel 2016, rimane un documento importante nel proporre la lettura teologica di un’ecologia integrale che, in qualche modo, si affianca a quella laica di Latouche.
Ti ringrazio per aver ricordato la mia semplice domanda sul fatto che la decrescita, che per me non ha senso se assolutizzata, ha avuto il merito di focalizzare l’attenzione sugli effetti negativi di uno sfruttamento sfrenato dell’ambiente e di averne indicato, in qualche modo aiutando, forse, attraverso la circolazione delle idee e il pluralismo delle posizioni, a correggerne le storture consumistiche. Almeno a livello di dibattito culturale. Un po’ come ha fatto Rousseau che, nel riportare l’individuo alla natura e nell’utilizzare l’espressione classica della bontà originaria dell’uomo che la società renderebbe “mechant”, non vuole, sono d’accordo con te, un ritorno a una condizione precivile, impossibile da realizzare, ma ribadire il ruolo dell’educazione nel processo di formazione dell’individuo, un’educazione che si pone come naturale, negativa (nel senso che interviene quanto meno possibile) e indiretta: fortunati, sicuramente, quei bambini che hanno potuto vivere la loro infanzia in campagna, a esperire ed esplorare un ambiente ricchissimo di stimoli! L’Emile ha rivoluzionato in modo decisivo il mondo dell’educazione e offerto nuove, preziose chiavi di lettura e di approccio pedagogico. E, ciononostante, Rousseau, cui va altresì il merito di aver proposto nel Contract social un modello politico anch’esso per noi imprescindibile, nel Discorso sulle scienze e le arti, intervenne in maniera tranchant nel contesto illuministico, attribuendo al progresso scientifico la responsabilità della corruzione dei costumi. Come poteva Voltaire non contestarlo? Come si poteva non criticarne la miopia nell’aver allontanato il pensiero dalla funzione democratica di un’operazione divulgativa come, ad esempio, l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers di Diderot e d’Alembert? Nella diatriba classica tra Voltaire e Rousseau, non voglio e non posso, date le mie limitate capacità, entrare: sono due grandissime figure del pensiero, entrambe fondamentali per ciò che ci hanno regalato, sia pure da angolazioni diverse. Per tornare a Ferraris, di cui forse si sarebbe potuto rilevare la perentorietà di alcune affermazioni (penso a quelle sui terremoti), credo che abbia voluto, con il richiamo a Rousseau, piuttosto assumerne la tesi più nota e controcorrente, quella di un uomo che allo stato di natura è libero e buono, per criticarne il senso e le implicazioni. Per lui, e anche per me, lo stato, sia pure “idealtipico”, di una libertà e bontà originarie che la società avrebbe inquinato, confligge con la realtà di una condizione che di umano ha poco, nel senso che l’uomo è cultura nella misura in cui riesce a emanciparsi dall’asservimento a un ambiente esterno da cui la sua esistenza è minacciata. L’uomo primitivo non era libero, perché incapace di contrastarne gli effetti devastanti, e non poteva essere buono, dal momento che la bontà è un valore che attiene all’etica e che, per sua necessità, implica l’alterità: io sono buono o cattivo in relazione a un altro, non se vivo in un eremo. La società è incontro, confronto e scontro, conflittualità e corruzione ma anche il campo in cui far emergere bellezza, sensibilità e intelligenza: è la cultura che mi impedisce di risolvere tutto con la forza bruta. Ed è all’interno delle sue dinamiche che mi pongo come buono o come malvagio. Il “bestione“ di vichiana memoria, che “sente senza avvertire”, che vive in uno stato ferino e in una realtà ostile da cui deve difendersi, cosa che può fare con la fantasia e con la ragione, caratteristiche peculiarmente umane, avvia un percorso di incivilimento che lo porta ad allontanarsi dalla sua condizione originaria. Come può essere libero in tale schiavitù? Lo è potenzialmente, perché possiede in sé le qualità per avviare tale processo, ma per “attualizzarle” deve uscire da un immobilismo conservatore e slatentizzarle e ciò è possibile grazie alla sua intelligenza pratica che lo spinge, attraverso il lavoro e dunque la tecnica, a vincere le difficoltà. Ovviamente è un cammino impervio, in cui i successi della ragione si affiancano ai suoi fallimenti, in cui il male può prevalere sul bene, in un alternarsi di corsi e ricorsi storici che richiedono vigilanza e senso del limite. Ma è necessario».


.jpg)